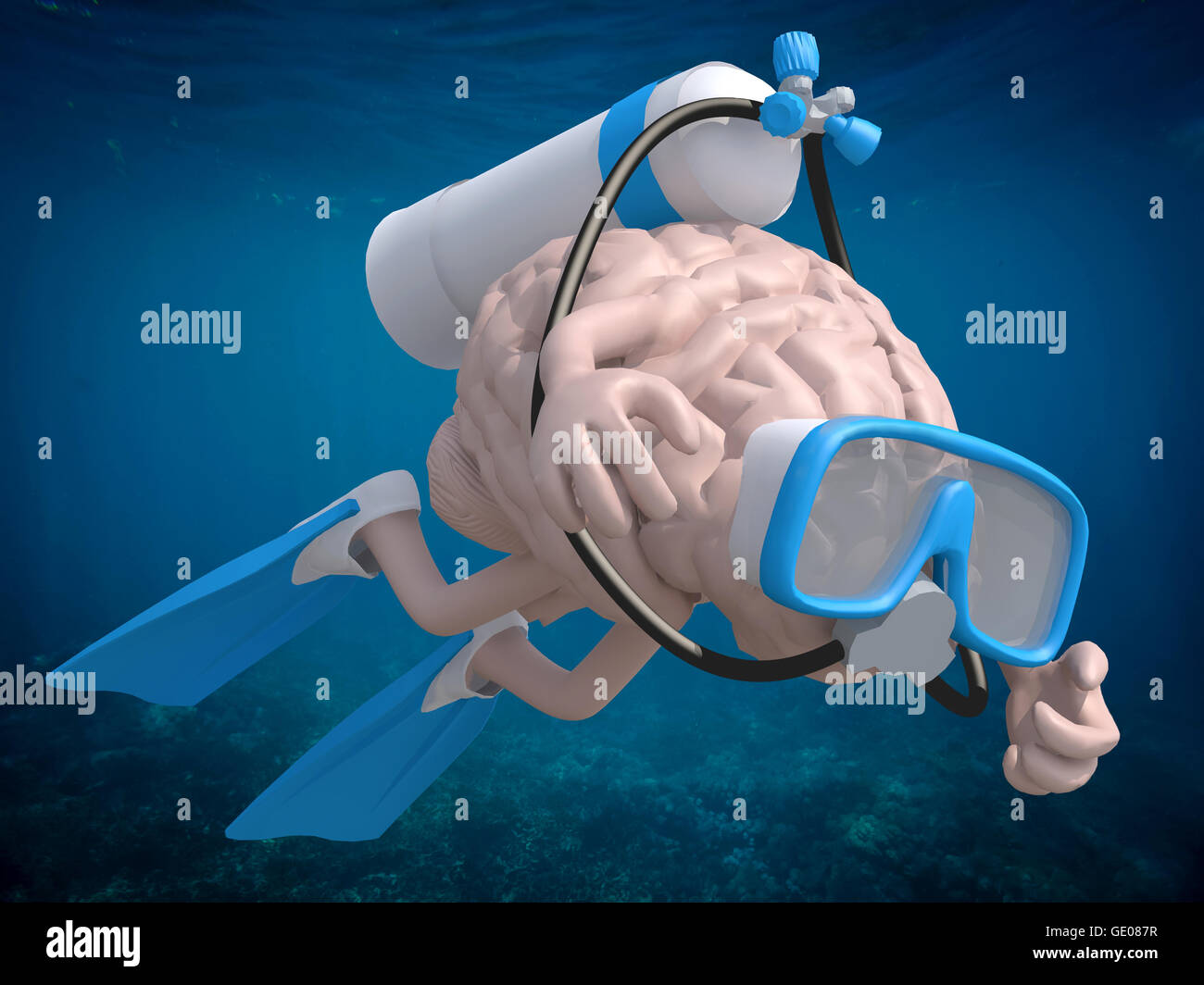di Jenna Wiley
Continuiamo a indagare la eventuale relazione tra lesioni acute da immersione e complicazioni neurologiche. La questione è ancora irrisolta. Poniamo agli esperti una seconda serie di domande per capire meglio gli effetti dell'attività subacquea sul cervello.
Qual è la relazione tra una riduzione delle facoltà neuropsicologiche e la presenza di lesioni cerebrali?
Moon: Finora, nessuno ha provato che nei subacquei esista una tale relazione.
Uzun: La presenza di lesioni cerebrali non indica necessariamente una riduzione nelle funzioni neuropsicologiche. È pur vero che ci sono studi che confermano una correlazione tra lesioni della sostanza bianca e deterioramento cognitivo negli anziani, e che altri suggeriscono che le lesioni della sostanza bianca periventricolare siano predittive di un futuro sviluppo della demenza; ma è anche vero che gli studi valutativi del rapporto tra lesioni cerebrali e funzioni neuropsicologiche nei subacquei non hanno trovato alcuna correlazione.
Tetzlaff: Si è scoperto che il deterioramento delle funzioni esecutive e della memoria è strettamente associato alle lesioni cerebrali della sostanza bianca.

Qual è la relazione tra apnea volontaria, ipossia, e la possibilità di lesioni cerebrali negli apneisti?
Moon: Quando un apneista raggiunge la superficie, il suo livello di ossigeno nel sangue può essere tanto basso (ipossiemia) da causare la perdita di conoscenza per qualche secondo. È possibile che il ripetersi di tali episodi ipossici provochi un danno cerebrale cumulativo.
Uzun: Ci sono delle ricerche sui danni cerebrali negli apneisti. Recentemente, uno studio (Andersson et al., 2009) ha rilevato un incremento, subito dopo l'apnea volontaria, nei livelli sierici della proteina S100B, un marcatore di danno neuronale. I ricercatori ipotizzano che questo possa segnalare un danno neuronale da ipossia o un temporaneo deterioramento della barriera emato-encefalica. Ma non è ancora chiaro se l'apnea volontaria sia causa di danni cerebrali a lungo termine.
Tetzlaff: Trattenere a lungo il respiro riduce l'ossigenazione del cervello. Gli studi sulle apnee ostruttive del sonno provano che l'ipossia intermittente è associata a declino cognitivo e a infarti cerebrali silenti, che riguardano soprattutto la malattia cerebrovascolare dei piccoli vasi. Tuttavia, a differenza dei pazienti con apnea ostruttiva del sonno, gli apneisti non sembrano sviluppare uno stato permanente di attivazione del simpatico o di riflessi cardiovascolari rilevanti. L'incremento nella concentrazione sierica della proteina S100B (un marcatore di danno cerebrale) dopo apnee estreme, effettuate da apneisti di altissimo livello, potrebbe indicare la probabile compromissione della barriera emato-encefalica. Ma la S100B è un marcatore non specifico e può essere aumentata da lesioni extracraniche. L'apnea estrema, così come viene effettuata dai grandi apneisti, è causa di notevole stress sui sistemi cardiovascolare e respiratorio. Va detto che l'apnea estrema è un'attività pericolosa che può avere conseguenze gravi, tra le quali un danno cerebrale a lungo termine è la meno preoccupante.

L'attività subacquea a quali rischi espone il sistema nervoso centrale di una persona?
Moon: Il rischio più grande, anche se basso, è la malattia da decompressione (PDD) cerebrale. Può essere conseguente o a MDD, con le bolle formate nei tessuti e nei vasi sanguigni che potrebbero arrivare al cervello, o a embolia gassosa arteriosa (EGA), dove le bolle risultano dalla lacerazione degli alveoli dovuta al trattenere il respiro durante la risalita o a malattie polmonari.
Uzun: Le immersioni con autorespiratore sono associate a diversi rischi neurologici, tra i quali la MDD, l'EGA, l'anossia e la sindrome nervosa da alta pressione.
Tetzlaff: I danni più gravi per il sistema nervoso centrale sono prodotti dall'embolia gassosa delle arterie cerebrali, che può essere rapidamente innescata da un'EGA conseguente a un barotrauma polmonare o al riversarsi di emboli gassosi venosi nella circolazione arteriosa (come può accadere in caso di presenza di FOP). Anche un'embolia silente dei microvasi cerebrali con bolle di gas inerte può causare danni permanenti. Vale a dire che immersioni tranquille ed entro i limiti di non decompressione dovrebbero ridurre al minimo i rischi per il sistema nervoso centrale.
I subacquei con autorespiratore che non hanno mai avuto una PDD si devono preoccupare per danni cumulativi a lungo termine dovuti alle immersioni?
Moon: No.
Uzun: No. Al momento non c'è nessuna prova convincente che l'attività subacquea con autorespiratore provochi danni cerebrali a lungo termine in subacquei asintomatici.
Tetzlaff: Non c'è motivo di preoccuparsi. Come abbiamo spiegato prima, una malattia ischemica dei vasi cerebrali può derivare da bolle di gas dovute alle immersioni, ma immergersi entro i limiti consigliati e seguendo le procedure consigliate dovrebbe prevenire questo tipo di problemi.
Incontra gli Esperti
Richard Moon, MD, si è laureato in medicina presso la McGill University di Montreal, Canada. È professore di anestesiologia e medicina e direttore medico del Centro di Medicina Iperbarica e Fisiologia Ambientale presso il Duke University Medical Center a Durham, N.C.
Kay Tetzlaff, MD, è professore associato di medicina nel dipartimento di medicina dello sport presso l'università di Tubinga, in Germania, e consulente di medicina iperbarica e subacquea.
Günalp Uzun, MD, è professore associato di medicina subacquea e iperbarica presso il GMMA Haydarpasa Teaching Hospital di Istanbul, in Turchia.
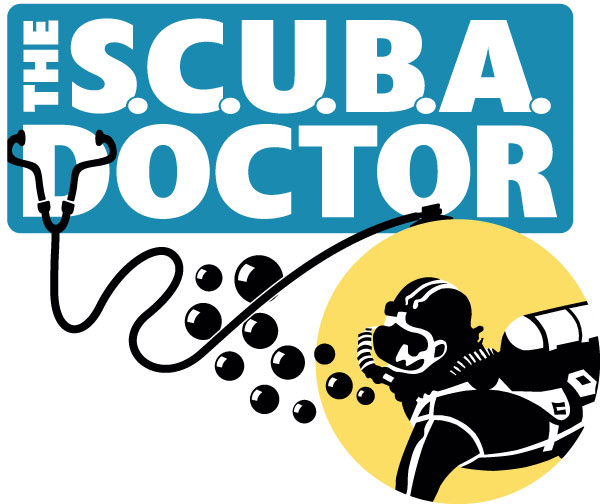
La ricerca attuale
Per capire meglio gli effetti dell'attività subacquea sul cervello, i ricercatori DAN hanno iniziato uno studio che prevede lo screening dei subacquei per gli effetti acuti delle immersioni sulle funzioni esecutive. Lo scopo dello studio è valutare le eventuali disfunzioni neurologiche dopo immersioni estreme in apnea e immersioni profonde con autorespiratore in subacquei asintomatici.
Per capire meglio gli effetti dell'attività subacquea sul cervello, i ricercatori DAN hanno iniziato uno studio che prevede lo screening dei subacquei per gli effetti acuti delle immersioni sulle funzioni esecutive. Lo scopo dello studio è valutare le eventuali disfunzioni neurologiche dopo immersioni estreme in apnea e immersioni profonde con autorespiratore in subacquei asintomatici.